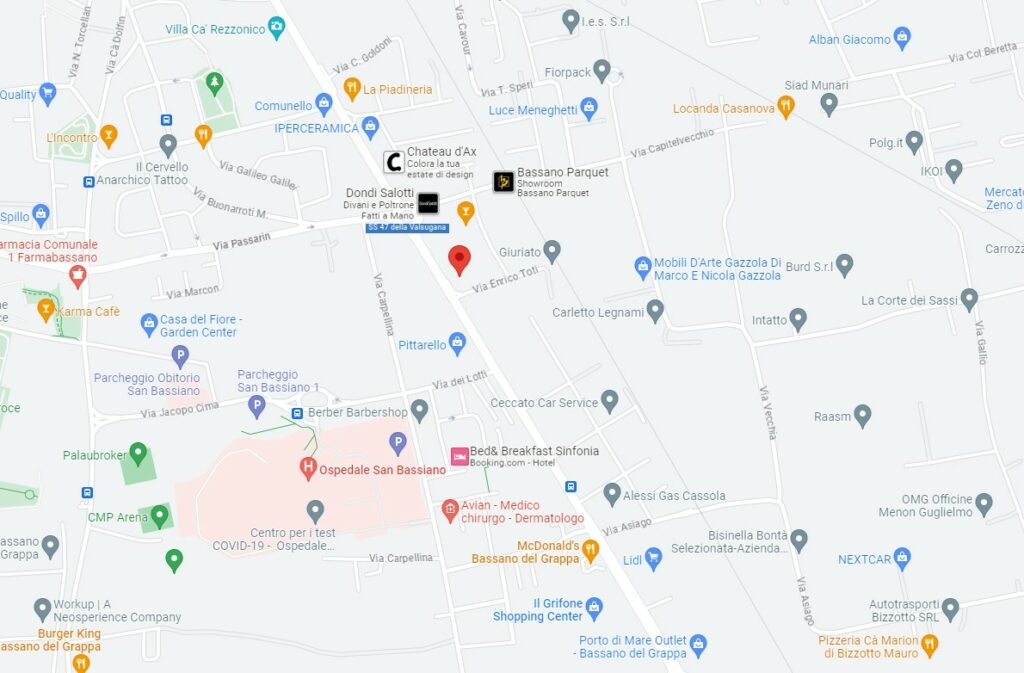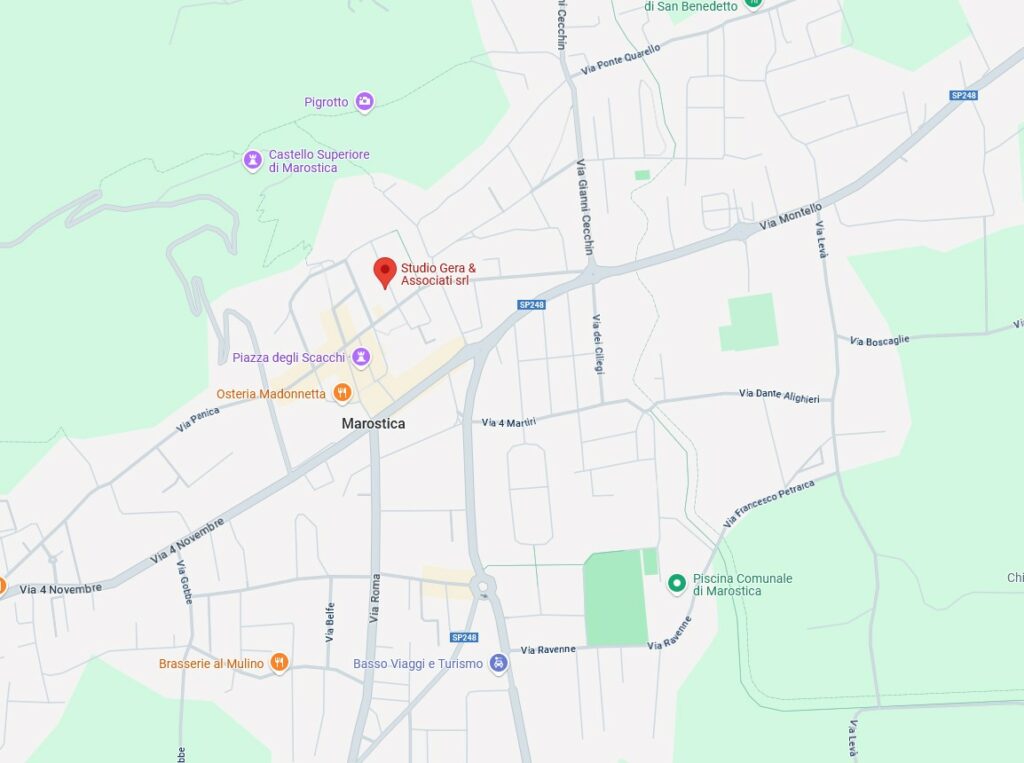In sostanza, per recuperare un importo di Iva è necessario emettere una nota di variazione, senza che ciò comporti rinuncia al credito.
Partiamo da quanto l’Agenzia delle Entrate precisa nella FAQ n. 96, la quale, pur essendo “aggiornata” al 19.07.2019, è ancora ritenuta “attuale” e pubblicata sul sito istituzionale.
La domanda è: come si emette una nota di variazione, per il recupero dell’Iva su una procedura concorsuale?
Ricordiamo che a seguito dell’infruttuosità accertata (in sede di chiusura) o presunta (in sede di apertura) di una procedura concorsuale, è dato al creditore la facoltà di chiedere all’Erario la restituzione dell’Iva a suo tempo versata, per aver emesso una fattura nei confronti del proprio debitore, poi assoggettato a procedura, e mai incassata.
Per bizantinismi solo italiani, il creditore concorsuale, per recuperare tale Iva, deve emettere una “nota di variazione”, che l’Erario italiano considera in modo abbastanza curioso come una “detrazione dell’Iva”, ma che in realtà va registrata con il segno negativo tra le operazioni attive, e non certamente con segno positivo tra quelle passive.
Le modalità di emissione di questa nota di variazione sono talmente importanti, che il destinatario (cioè l’organo della procedura), si disinteressa completamente di tale documento, non dovendo registrarlo, e né tantomeno far nascere debiti Iva al suo ricevimento.
Anzi, per le vecchie procedure concorsuali, per le quali la nota di variazione va emessa alla chiusura della stessa, non di rado capita che la partita Iva della procedura sia chiusa, ed addirittura il documento venga scartato.
Ovviamente al lettore non serve ricordare che – pur emettendo una nota di variazione – il creditore mantiene il suo credito verso il proprio debitore; ciò è tanto più vero oggi che, con le nuove procedure, le note di variazione vanno emesse all’apertura della procedura, e quindi l’organo della stessa deve avere ben chiaro che il credito originario dovrà partecipare interamente al riparto.
In sostanza, per recuperare un importo di Iva è necessario emettere una nota di variazione, senza che ciò comporti rinuncia al credito.
Torniamo alla “attuale” FAQ 96, con la quale si chiede se sia corretto fare una nota di variazione con imponibile ed Iva, e poi annullare l’importo dell’imponibile con una voce di segno contrario in fuori campo Iva.
L’Agenzia delle Entrate risponde che non è corretto e che è necessario emettere (con segno negativo) una fattura elettronica con solo Iva utilizzando il tipo documento “fattura semplificata”, e rinvia alla FAQ 27, con la quale viene spiegato che con il servizio telematico dell’Agenzia (e probabilmente solo con quello….) è possibile emettere un documento dove esiste l’Iva ma non esiste un imponibile.
Per fortuna della maggior parte dei contribuenti, quasi nessuno utilizza i servizi telematici dell’Agenzia, e quasi nessuno ha software in grado di emettere una nota di variazione dove non esiste l’imponibile.
Sembra che ce la abbia fatta, invece, il contribuente che ha presentato la risposta ad interpello 485/2022, e che ha avuto la sorpresa di sentirsi rispondere che con la risposta ad interpello 801/2021 la stessa Agenzia delle entrate avevano chiarito che “la variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell’imponibile che della relativa imposta” (cioè il contrario di quello che scrivono sulla FAQ).
Con tale risposta, in particolare, lasciavano intendere che se a fronte di un credito di 110 per una fattura con Iva del 10%, viene pagato solo il corrispettivo di 100, non si può sostenere che non sia stata pagata l’Iva e chiederne la integrale restituzione, ma è necessario spartire la perdita di 10 tra imponibile ed imposta.
Con la risposta ad interpello 485/2022, dove non c’è da spartire nulla in quanto si è in presenza di un fallimento appena aperto e quindi il credito deve essere stralciato per intero, arriva la sorpresa, posto che al contribuente che ha fatto quello che è spiegato nelle FAQ della stessa Agenzia, viene risposto che “la nota di variazione di sola Iva, così come emessa dall’istate, risulta quindi errata e, essendo ormai spirato il termine entro cui la stessa avrebbe potuto essere riemessa correttamente (30 aprile 2022) viene conseguentemente meno la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta in sede di dichiarazione Iva 2023”.
Una risposta, in sostanza, che sembra l’esaltazione del principio comunitario di effettività dell’imposta, secondo il quale la violazione di eventuali requisiti formali non può mai avere l’effetto di mettere in discussione la neutralità dell’Iva.
La risposta ad interpello contiene anche una importante apertura, auspicata da molti ed in primis da Assonime, e cioè che se si “perde” il momento corretto per emettere la nota di variazione secondo le nuove norme (entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di apertura della procedura), si riapre una finestra per poter emettere tale nota di variazione al termine della procedura, a condizione che ci sia insinuati nel passivo di tale procedura.
Tralasciando le motivazioni (non condivisibili) e le limitazioni (cioè di essere insinuati al passivo, altrettanto non condivisibili e bocciate dalla stessa Corte di Giustizia richiamata nell’interpello…) di tale assunto, l’apertura per il contribuente è notevole, ma visti i precedenti, magari poi con qualche FAQ a breve qualche altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate dirà che non è vero che si può fare.
da Euroconference News