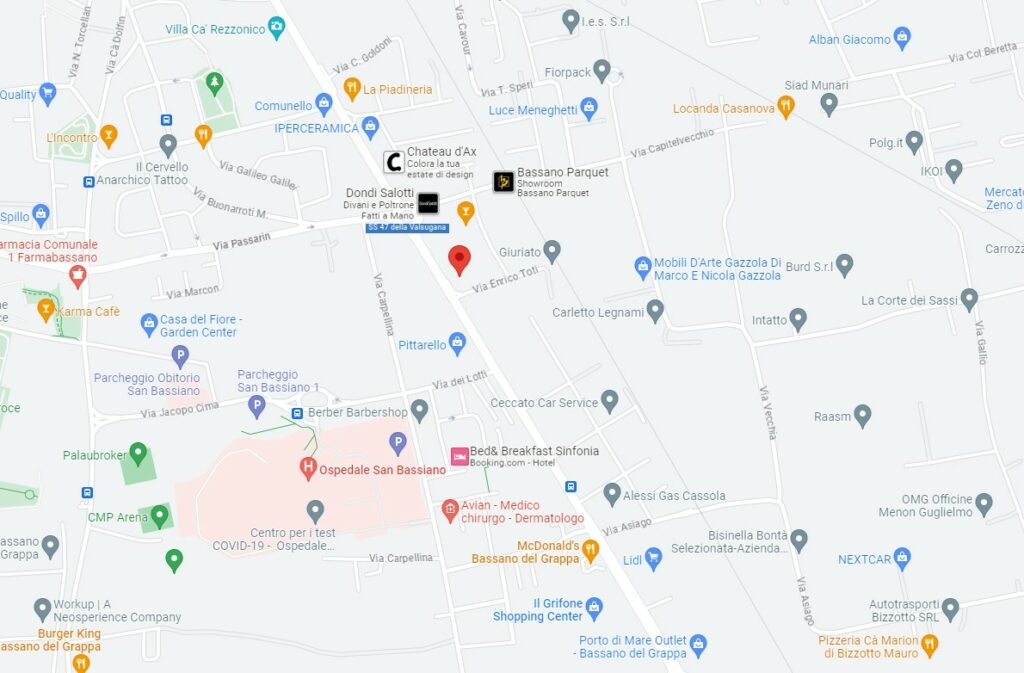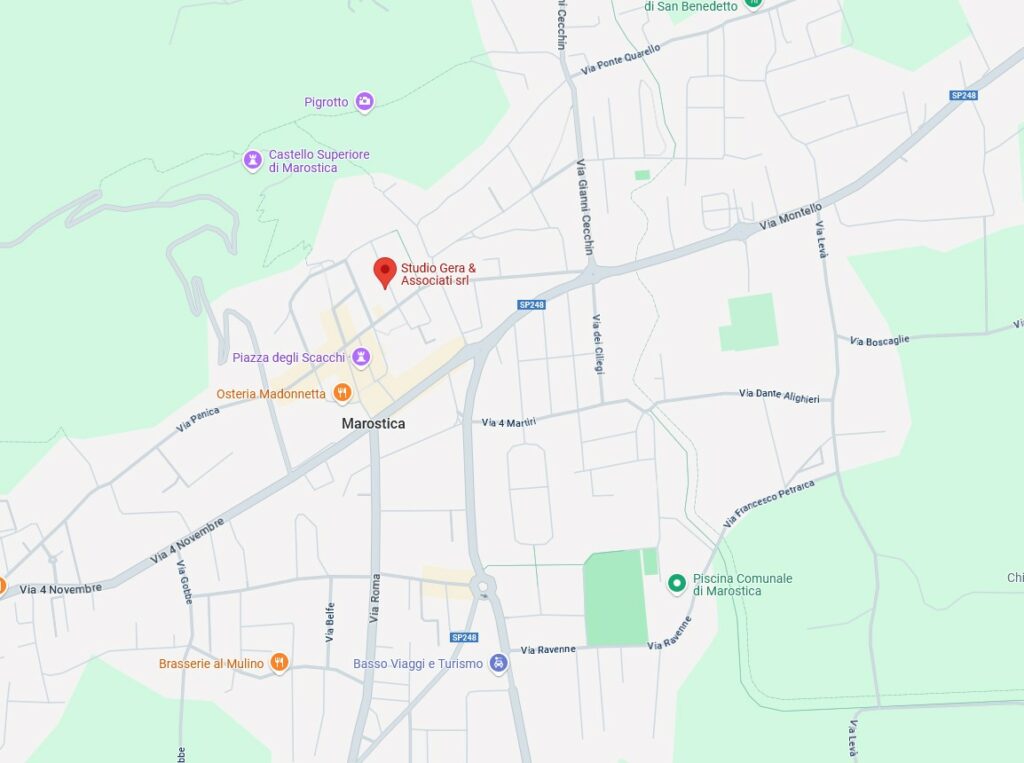L’Agenzia delle Entrate, nei giorni scorsi, ha pubblicato la circolare n. 18/E/2024 con cui sono stati forniti chiarimenti sul concordato preventivo biennale.
Alla luce di quanto di quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria, i contribuenti (e i loro consulenti) in queste settimane sono alle prese con i calcoli di convenienza rispetto alla proposta concordataria con qualche certezza in più.
Prima di valutare la proposta, però, occorre capire se i contribuenti rientrano nel perimetro applicativo del concordato preventivo biennale.
I controlli che i soggetti ISA devono operare sono di due tipi, essi devono verificare:
- la presenza dei requisiti di accesso, ai sensi dell’articolo 10, Lgs. 13/2024 (si tratta di una verifica in positivo);
- l’assenza delle cause di esclusione ai sensi dell’articolo 11, D.Lgs. 13/2024 (si tratta di una verifica in negativo).
I requisiti di accesso sono due:
- concreta applicazione degli ISA nel periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta (2023 per i soggetti solari). Il comma 1, dell’articolo 9, D.Lgs. 13/2024, disciplinando il profilo soggettivo del concordato, non cita i soggetti per la cui attività è approvato un ISA, ma fa riferimento ai soggetti che “applicano” gli ISA (ovvero coloro che non integrano una causa di esclusione dagli ISA, come ad esempio il superamento del limite di ricavi o primo periodo d’imposta di attività). L’Agenzia delle entrate, con la citata circolare, inoltre, ha chiarito che i soggetti multiattività non potranno accedere al concordato preventivo, in quanto non applicano gli ISA.
- assenza di debiti relativi a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e/o debiti contributivi con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta. I debiti che devono essere considerati sono quelli definitivamente accertati con sentenza irrevocabile (passata in giudicato) o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione (ad esempio un avviso di accertamento o una cartella di pagamento non impugnati). Tuttavia, il legislatore permette ai contribuenti di poter accedere al concordato, a condizione che, entro la data di accettazione della proposta, riducano il debito fiscale e/o contributivo (comprensivo di sanzioni e interessi) al di sotto della soglia di 5.000 euro. Non concorrono ai fini del limite di 5.000 euro i debiti oggetto di sospensione o di rateizzazione.
In merito a quest’ultimo punto l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che:
- la situazione debitoria deve essere verificata alla data del 12.2023;
- il limite di 5.000 euro è da considerarsi complessivamente, a nulla rilevando che sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia;
- in relazione ai soggetti trasparenti, il limite di 5.000 euro non deve essere considerato in capo ai soci;
- i debiti relativi ad istituti deflativi del contenzioso non rilevano.
Oltre a quanto sopra, il contribuente deve anche accertarsi di non rientrare in una delle seguenti cause di esclusione:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall’articolo 2621, cod. civ., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1, C.p., commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Sul punto l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la sentenza di condanna deve essere irrevocabile e il patteggiamento è rilevante se comporta una pena detentiva superiore a 2 anni;
- con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
- adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del Tuir è interessata da modifiche della compagine sociale.
L’Amministrazione finanziaria, in via interpretativa, ha assimilato la cessione d’azienda alle operazioni straordinarie che non permettono l’accesso al concordato ed ha confermato che non rileva, invece, l’eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale.
Da Euroconference News