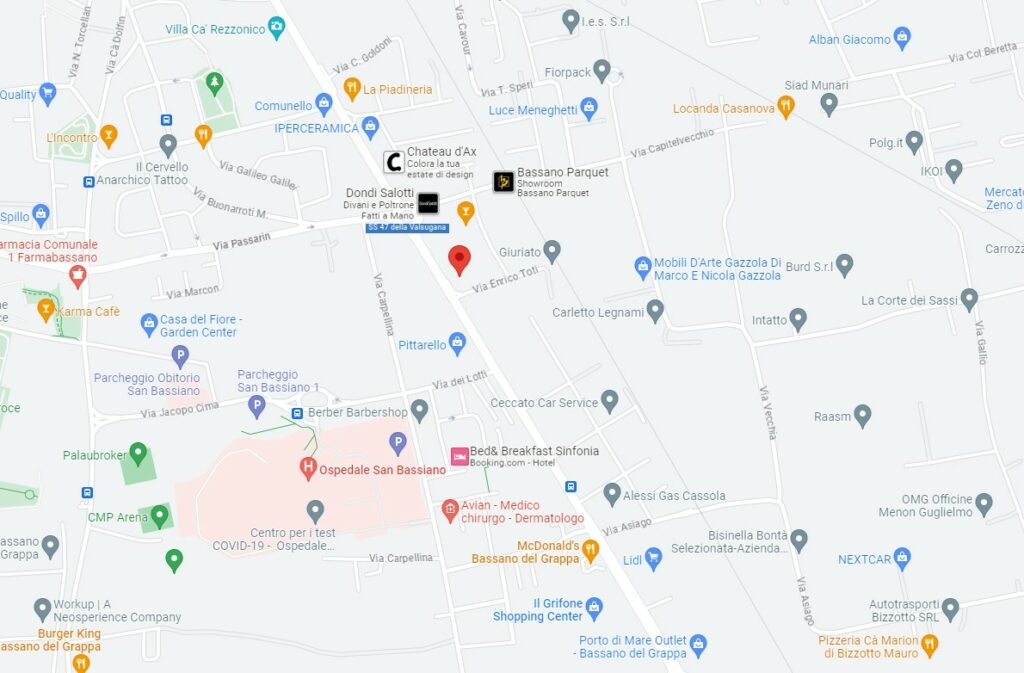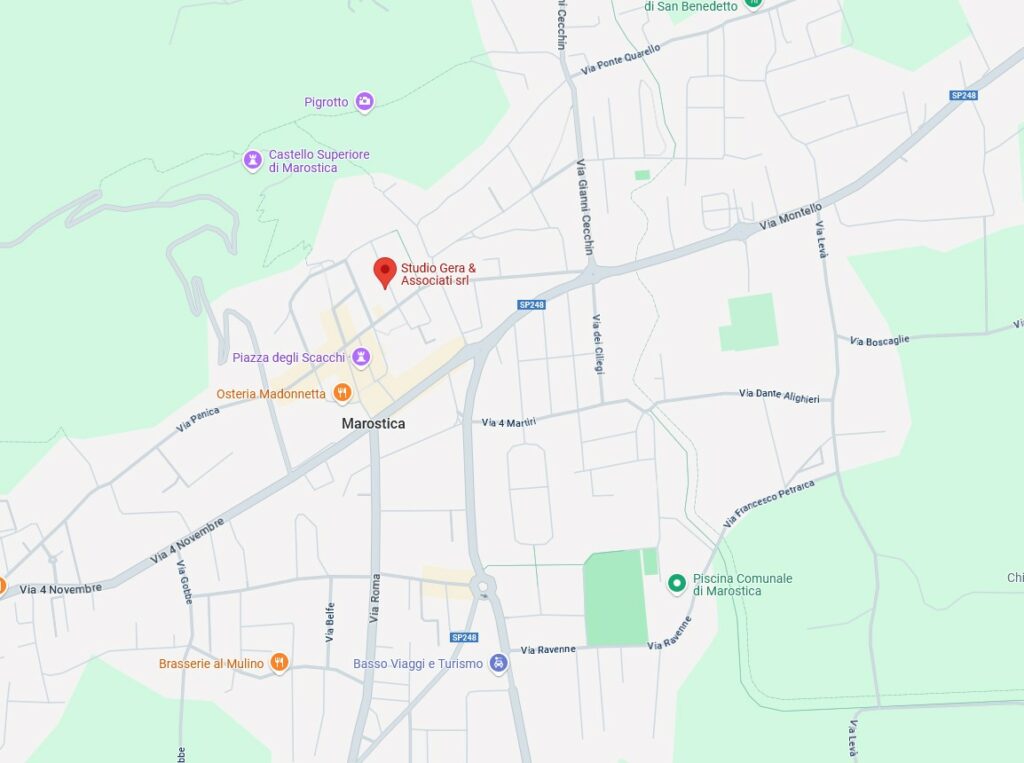Il legislatore ha previsto, in maniera piuttosto diffusa, la riscossione delle imposte mediante il meccanismo della sostituzione d’imposta.
Le ritenute che opera il sostituto d’imposta, individuato dall’articolo 23, D.P.R. 600/1973, possono essere effettuate a titolo di:
- imposta;
- acconto.
Le prime esauriscono il rapporto tributario, infatti, il contribuente, una volta subita la ritenuta, non ha più obblighi nei confronti dell’erario (compreso quello di presentare la dichiarazione fiscale). Si pensi, ad esempio, alle persone fisiche che percepiscono degli interessi attivi, a fronte di somme detenute in un conto corrente acceso presso un istituto di credito.
Le ritenute effettuale a titolo di acconto, invece, rappresentano solo un’anticipazione dell’imposta dovuta da parte del contribuente, il quale, dunque, è obbligato a dichiarare il reddito prodotto e di conseguenza a determinare l’imposta dovuta al netto della ritenuta subita; infatti, lo scomputo rappresenta una delle operazioni necessarie per determinare l’imposta dovuta o il credito fiscale maturato.
In questo contesto, s’inserisce quanto previsto dall’articolo 22, Tuir, il quale sancisce il diritto del contribuente a recuperare le ritenute subite. Nello specifico, il comma 1, della richiamata disposizione, prevede che:
- possono essere scomputate dall’imposta le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente (lettera a));
- le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate (lettera b));
- le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti (lettera c)).
Di particolare interesse è la lettera b), al comma 1, dell’articolo 22, Tuir.
I contribuenti che determinano il reddito in base al principio di cassa non sono interessati da tale disposizione, infatti, considerando che la ritenuta viene operata all’atto dell’erogazione del reddito, nel medesimo periodo d’imposta viene assoggettato a tassazione il reddito e viene subita la ritenuta.
Diverso è, invece, il caso di quei contribuenti che determinano il reddito in base al criterio della competenza economica: in tale ipotesi vi può essere una divaricazione tra la maturazione e l’incasso (con relativa effettuazione della ritenuta) del reddito.
Tali contribuenti possono avvalersi, pertanto, della disposizione contenuta nell’articolo 22, comma 1, lettera b), Tuir:
- se un reddito matura per competenza nel 2023 e viene incassato entro il termine di presentazione della dichiarazione fiscale, allora la ritenuta potrà essere scomputata dall’imposta 2023;
- se un reddito matura per competenza nel 2023 e viene incassato oltre il termine di presentazione della dichiarazione fiscale, allora la ritenuta potrà essere scomputata in relazione al periodo d’imposta in cui viene operata.
In questo secondo caso, dunque, vi sarà uno sfasamento temporale tra:
- il periodo d’imposta di tassazione del reddito (quello di maturazione) e;
- il periodo d’imposta di scomputo della ritenuta (quello dell’incasso).
La medesima disposizione è contenuta nell’articolo 25-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973, secondo cui “la ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata”.
Le attuali disposizioni normative sono state oggetto di modifica da parte del D.L. 193/2016, il quale ha ampliato, come in precedenza visto, l’ambito temporale per scomputare le ritenute subite (la disposizione previgente disponeva lo scomputo nel periodo d’imposta di competenza), tuttavia occorre sottolineare che, comunque, in tema di provvigioni, un’apertura in tal senso era pervenuta dall’Amministrazione finanziaria (circolare n. 24/E/1983), la quale aveva chiarito che “le ritenute… ove per qualsiasi ragione non vengano scomputate dall’imposta dell’anno cui sono imputabili le provvigioni medesime, potranno essere comunque detratte dall’imposta dell’anno in cui le provvigioni stesse sono state pagate”.
da Euroconference News