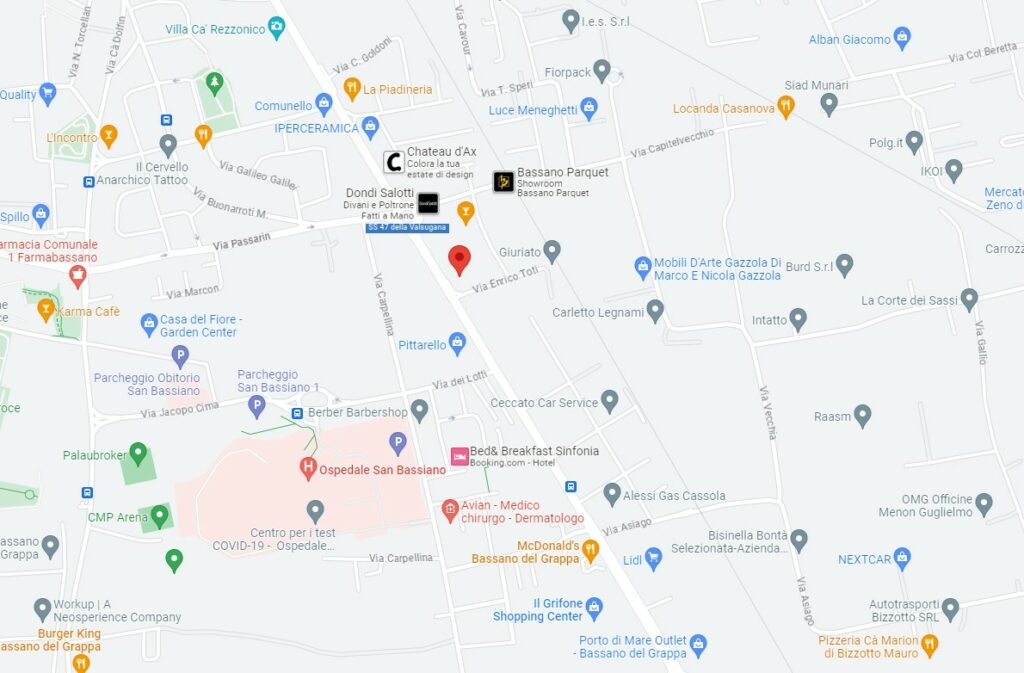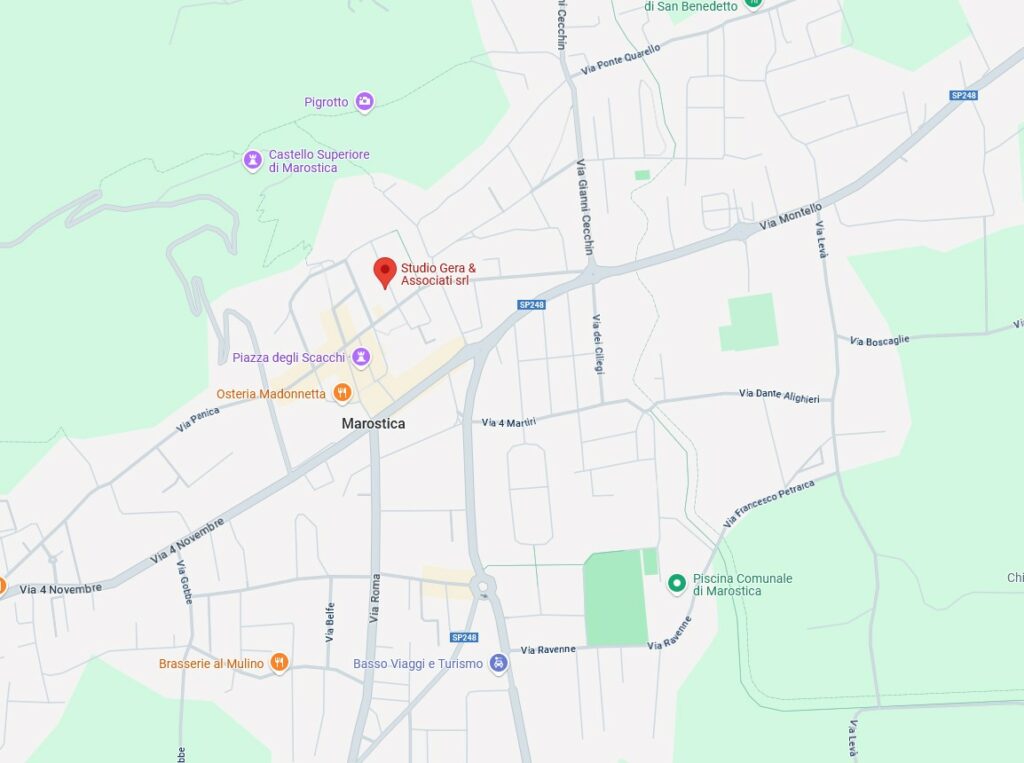La vendita dell’energia elettrica al Gestore dei servizi energetici (GSE) sulla base dell’apposita tariffa contrattuale è fiscalmente rilevante ai fini Irpef nella categoria dei redditi diversi. Il GSE corrisponde infatti un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.
Tra i prossimi soggetti obbligati a trasmettere informazioni al Fisco al fine di predisporre le dichiarazioni precompilate, l’Agenzia delle Entrate, nella recente circolare n. 8/E/2024, annovera infatti il Gestore dei servizi energetici S.p.A., al quale verrà richiesto di trasmettere i dati relativi ai proventi corrisposti al responsabile dell’impianto, persona fisica, che ha optato per la vendita dell’energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico, risultata esuberante rispetto ai propri bisogni energetici.
Gli impianti fotovoltaici considerati “domestici” sono quelli di proprietà di soggetti privati con potenza inferiore ai 20 KWh, per i quali, nel caso di cessione dell’energia prodotta in eccesso rispetto ai bisogni dell’abitazione, non si è in presenza di una vera e propria attività commerciale e tali contributi ricevuti dal GSE sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. i) del Tuir. Ciò significa che tali redditi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi come derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, nel quadro D, rigo D5 del modello 730 o nel quadro RL, rigo RL14 per chi compila il modello Redditi PF.
Ovviamente tale problema non si pone nel caso in cui l’impianto fotovoltaico di tipo domestico (con potenza non superiore ai 20KWh) sia asservito totalmente ai fabbisogni energetici dell’abitazione senza immissione in rete dell’energia elettrica.
Che i redditi derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche (se generata da impianti di potenza fino a 20 kW posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale) non si configurino come svolgimento di un’attività commerciale è stato chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E/2007.
La segnalazione di questa categoria reddituale all’interno della circolare 11.04.2024, n. 8/E non deve essere dunque sottovalutata dai contribuenti. Il senso della disposizione è quantomeno duplice.
Da un lato, infatti, l’Amministrazione Finanziaria ricorda, proprio nel pieno della campagna dichiarativa 2024, come tali proventi riscossi dal GSE nel corso del 2023 siano da assoggettare a tassazione Irpef con le regole sopra ricordate prendendo a riferimento l’apposta certificazione rilasciata annualmente dal Gestore dei servizi energetici.
Dall’altro lato, invece, lascia trasparire una precisa volontà del Fisco di conoscere, tramite il nuovo obbligo di trasmissione delle informazioni al GSE, i dati dei citati redditi al preciso scopo di avviare controlli incrociati con relative rettifiche in caso di mancata indicazione dei redditi stessi nelle dichiarazioni annuali presentati dai proprietari degli impianti fotovoltaici domestici.
Si tratta dunque di precisazioni molto importanti, che dovranno essere considerate con estrema attenzione sia al preciso fine di indicare nella dichiarazione dei redditi del 2023 i redditi conseguiti dal GSE grazie al cosiddetto “scambio sul posto” dell’energia eccedente immessa in rete, sia per considerare, qualora ve ne fosse bisogno, il corretto adempimento dichiarativo anche per le annualità precedenti.
Da Sistema Ratio